La partita del referendum
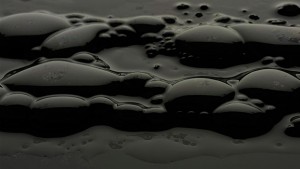 Annalisa Corrado su Sbilanciamoci.info
Annalisa Corrado su Sbilanciamoci.info
La vittoria del SI al referendum del 17 aprile potrebbe dare una spallata ad un castello di bugie e mostrare che la strada verso la democrazia energetica, verso una promozione sostenibile dei talenti sani dei nostri territori (paesaggio, cultura, turismo, pesca e agricoltura sostenibili, eccellenze agro-alimentari) è segnata e che non si torna più indietro
Pensavo fosse incompetenza o mancanza di visione. Fresca di laurea, folgorata sulla via dell’energia come “madre di tutte le battaglie” da combattere (contro le crisi internazionali, i ricatti dei potenti detentori delle risorse, contro le crisi sociale, ambientale e poi anche economica), ero ingegneristicamente innamorata dell’idea che sole, vento, biomassa, maree e calore della Terra, assieme alle intelligenti evoluzioni della tecnologia, avrebbero mostrato di lì a poco la via per costruire una nuova “democrazia energetica” e, ingenuamente, pensavo il freno fosse causato “solo” dalla manifesta incapacità strategica di un apparato politico/burocratico stanco, cinico e clientelare.
E invece sbagliavo di grosso.
La strategia esiste. Esiste e appare dettata da un potere apartitico (evidente se si analizza l’assoluta continuità nelle scelte fossili degli ultimi 4 governi, dalla destra di Berlusconi/Romani, ai tecnici Monti/Passera, passando per la “sinistra” di Letta/Zanonato, fino al governo del partito della “nazione” di Renzi/Guidi, il più fossile di tutti) gestito attraverso schiere di azzeccagarbugli che usano la normativa contro i cittadini, contro la partecipazione, contro le migliori idee ed energie del Paese.
L’ascolto è riservato esclusivamente ai soliti noti, per i quali un varco nel ginepraio della burocrazia si riesce sempre ad aprire (le autostrade, gli inceneritori, il cemento, le trivelle dello “sbloccaItalia” ne sono la manifestazione plastica).
La “strategia” esiste, e ci sono almeno due campi di gioco.
Il primo campo è quello del sistematico affossamento di uno dei settori economici più promettente del nostro Paese, quello delle fonti rinnovabili, che hanno l’enorme colpa di aver iniziato a dimostrare di essere pronte, da subito, a fare la propria parte (il 40% dell’energia elettrica prodotta in Italia nel 2014 deriva da fonti rinnovabili), senza restare confinate nella nicchia che si era pensata per loro. Lungi dal considerare un successo questa straordinaria progressione, ci si è immediatamente preoccupati per la progressiva inutilità delle turbo-gas a metano, installate come funghi nel recente passato.
Ne è seguita una campagna mediatica impressionante che punta il dito sul “costo delle rinnovabili in bolletta”, che sarebbero le responsabili della pesantezza della spesa energetica sulle famiglie italiane; si tace però sul fatto che le risorse fossili ricevono dallo Stato agevolazioni di ogni genere e finanziamenti diretti/indiretti stimati in circa 14 miliardi di euro/anno, e che il grande beneficio delle rinnovabili sul prezzo dell’energia all’ingrosso rimane spartito nel mercato dei grossisti, a causa di un complicatissimo meccanismo con il quale tale prezzo viene stabilito.
Alla campagna mediatica si sono associate azioni gravissime:
- sistemi di incentivazione di respiro breve/brevissimo (in primis il conto energia per il fotovoltaico), modificati “in corsa” senza interlocuzione con gli operatori e poi troncati (persino sugli interventi che consentivano le bonifiche di coperture in eternit),
- normative monche che paralizzano per anni settori promettenti (solare termo-dinamico e bio-metano, ad esempio),
- incapacità del sistema di tenere sotto controlli i tempi per le autorizzazioni (eolico o idroelettrico), anche per la presenza di interlocutori multipli e ridondanti, con procedure variabili nei diversi territori.
Come se non bastasse, grazie al governo Renzi, è arrivato lo “spalmaincentivi” che ha ritoccato retroattivamente al ribasso, su impianti già attivi, il valore dell’incentivo previsto; poi i bastoni tra le ruote all’autoconsumo, poi gli attacchi all’efficienza energetica, poi il nuovo decreto sulle rinnovabili non fotovoltaiche in cui spicca un contributo esplicito per gli inceneritori. Poi una lista che potrebbe continuare per pagine di rabbia, il cui effetto si può facilmente sintetizzare con un paio di numeri: investimenti passati dai 31 miliardi di dollari del 2011, a meno di un miliardo nel 2015, decine di migliaia di posti di lavoro persi (con un nucleo attualmente resistente di circa 75.000 addetti, ma un potenziale occupazionale incredibilmente maggiore, che non aspetta altro di essere liberato da trappole e trucchi, per poter correre correttamente sul mercato).
Sul campo numero due si gioca la partita che interessa più direttamente il referendum: la costruzione del miraggio della irrinunciabilità, per il nostro sistema Paese, dell’utilizzo delle fonti fossili (metano e petrolio) presenti nel sottosuolo.
Il governo Monti, con il decreto sviluppo, riaprì la strada a permessi di ricerca e coltivazione (estrazione) entro le 12 miglia marine dalla costa, che la Prestigiacomo, sull’onda del terribile incidente nel golfo del Messico, aveva bloccato; più recentemente, nello sbloccaItalia di Renzi, sono arrivati una serie di “semafori verdi” per rilanciare lo sfruttamento degli idrocarburi (attività con una filiera ad altissimo impatto ambientale e a bassissima densità lavorativa), agendo pesantemente anche sulla possibilità delle Regioni di partecipare almeno “alla pari” alle decisioni relative ai permessi.
Il tutto per favorire lo sfruttamento di risorse fossili che darebbero all’Italia una “indipendenza energetica” complessiva di alcune settimane, in un reale “accanimento terapeutico” contro l’ambiente (espressione di Leonardo Maugeri, per 10 anni direttore delle strategie di ENI), per cercare di prolungare di qualche anno un sistema per il quale molti territori italiani hanno già pagato e stanno pagando un prezzo altissimo (come la Basilicata: 80% della produzione nazionale di petrolio, il PIL tra i più bassi d’Italia, zone spopolate a causa dei gravissimi danni ambientali e preziosissime falde acquifere a rischio; Regione in prima linea contro il governo).
Si vuole, cioè, insistere con un sistema che si inchina alle compagnie a svantaggio dei territori, con le royalties tra le più basse al mondo drogate da agevolazioni che prevedono che le prime 20.000 ton di petrolio e 25 milioni di Smc di gas estratti in terraferma, come le prime 50.000 ton e 80 milioni di Smc in mare, siano esenti dal pagamento di aliquote.
Stiamo parlando, attualmente, di un introito complessivo nelle casse dello Stato che oscilla tra i 300-400 M€/anno (più o meno la stessa cifra che il governo ha “bruciato” in un solo giorno, per evitare l’accorpamento del referendum con le elezioni amministrative).
Quello che il governo non si aspettava è stato il trovarsi sbarrato il passo da una corposissima azione su più livelli (campagne di associazioni ambientaliste, comitati spontanei e organizzati, raccolte firme per attivare referendum popolari, cortei nazionali come quello di Lanciano con 60.000 persone in strada) che è confluita nella decisione di ben 10 Regioni (in molti casi a guida politica del medesimo colore del governo) a ricorrere all’estrema ratio del referendum.
Grazie a quest’onda d’urto, il governo ha dovuto rimangiarsi gran parte delle scelte fatte (in particolare circa la strategicità delle opere e circa la possibilità di riaprire il campo a moltissime concessioni entro le 12 miglia), scegliendo però un’azione legislativa all’interno della legge di stabilità molto poco trasparente, che, di fatto, nel cedere su più punti alla pressione #NOTriv, ha creato le condizioni per un vero e proprio condono alle concessioni già attive entro le 12 miglia.
Le compagnie concessionarie, improvvisamente e contro ogni principio di gestione dei beni pubblici e della concorrenza, in barba ad ogni considerazione relativa al rispetto dei parametri ambientali concordati (il 70% delle piattaforme operano in gravissimo sforamento dei parametri) vedrebbero cambiare i termini del contratto, avendo la possibilità di gestire le concessioni “fino ad esaurimento dei giacimenti”.
Un regalo che si tradurrebbe in una pericolosa incertezza circa gli obblighi di messa in sicurezza delle aree e di ripristino delle condizioni ambientali a fine concessione, in una riduzione ulteriore delle royalties (nel combinato disposto di tempi più lunghi e della citata “franchigia” sui primi quantitativi estratti), e che farebbe rientrare dalla finestra, potenzialmente, persino la realizzazione di nuovi impianti di estrazione, in barba al divieto entro le 12 miglia, purché previsti dalle concessioni già attive.
Il voto del 17 aprile sarà centrato sulla richiesta di annullare i benefici di tale condono. Ma la partita che si gioca, nell’ottica della strategia complessiva qui sinteticamente descritta, è di tutt’altro livello.
Il cavallo di battaglia dei promotori del “no” (o, peggio, dell’astensione), sarebbe quello dell’inutilità di questo quesito, descritto come il suicidio di un popolo che rinuncia al proprio futuro: in pochissimi, però, ricordano che una scelta del genere arriverebbe in assoluta coerenza con i recentissimi impegni che il nostro governo ha sottoscritto assieme ad altri 194 Paesi durante la COP21 di Parigi, che a dicembre scorso ha messo per sempre le fossili “dalla parte sbagliata della storia”.
Per contenere i cambiamenti climatici entro una soglia sostenibile per il pianeta (2 gradi centigradi di innalzamento della temperatura media, ma meglio se 1,5), il processo strategico di decarbonizzazione dell’economia deve vedere un’immediata e importantissima accelerazione che prevede, tra le altre cose, che i 2/3 delle risorse fossili (metano compreso) debbano restare nel sottosuolo, senza “se” e senza “ma”.
La vittoria del si bloccherebbe progressivamente, in circa 10 anni, la produzione di quantitativi di gas metano pari al 3% del consumo nazionale e di petrolio di meno dell’1%: in un tempo decisamente minore si può compensare tale perdita con interventi minimi di efficientamento energetico (di strutture pubbliche, di processi produttivi, di abitazioni), potenziando un settore strategico, perfettamente in grado di riassorbire le eventuali perdite di posti di lavoro “oil&gas”.
Davvero un Paese che dovrà, assieme all’Europa, ridurre le proprie emissioni almeno del 60-70% entro il 2050 può temere un impegno così contenuto?
Davvero, in un Paese che ha pagato lo scorso anno il prezzo di 84.400 morti premature per inquinamento, si vuole credere che esista ancora una possibilità di cedere al ricatto salute-lavoro?
Davvero si pensa che il lavoro o l’indipendenza energetica verranno da un’industria fortemente sovvenzionata, destinata inesorabilmente ad esaurirsi, mentre si sceglie di riempire di zavorra i percorsi di costruzioni delle filiere industriali nazionali legate alle rinnovabili, all’efficienza energetica e si dimentica sistematicamente di investire su quei sistemi di mobilità nuova e sostenibile che ridurrebbero i consumi e gioverebbero a salute e benessere?
Questo referendum, dalla gittata apparentemente contenuta, ha invece un potere dirompente, perché la vittoria del SI può dare una spallata ad un castello di bugie, può mostrare che la strada verso la democrazia energetica, verso una promozione sostenibile dei talenti sani dei nostri territori (paesaggio, cultura, turismo, pesca e agricoltura sostenibili, eccellenze agro-alimentari) è segnata e che non si torna più indietro.
Un “sì” fermo e collettivo può essere il sasso che Davide scaglia contro Golia.
Può essere la mossa del cavallo, che balza fuori dal piano della discussione su cui fittiziamente vuole tenerti l’avversario, e vince la partita intera.


